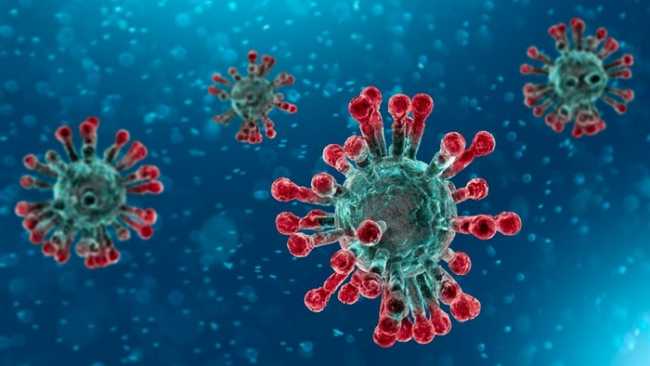VERBANIA - 22-03-2020 -- Qual è il confine
tra privacy e tutela della salute pubblica? Il limite oltre il quale cade il diritto alla riservatezza di ciascuno in nome di un interesse più grande? La domanda non è retorica e quotidianamente viene rilanciata -anche da diversi lettori- quando si parla di contenere il contagio di Covid-19. Perché conoscere chi è positivo al virus e si trova in quarantena (o, peggio, all’ospedale) può aiutare chi è venuto a contatto con quella persona affinché si tuteli o avvisi le autorità sanitarie.
Stare tutti a casa è la soluzione più drastica e più efficace per non far “camminare” il virus. Se nessuno uscisse per 14 o più giorni (il numero esatto lo devono stabilire i medici), in linea teorica il problema si risolverebbe alla radice. I malati meno gravi guarirebbero e non vi sarebbe alcun nuovo contagio. Nella pratica, così non è, perché bloccare tutte le attività per 60 milioni di persone è impossibile. Vanno quindi ridotte le possibilità di trasmissione del coronavirus. Ma ciò è possibile, soprattutto nelle piccole comunità come le nostre, anche con un controllo del territorio operato dal basso. L’identità di chi è contagiato o in quarantena è un dato in possesso dell’Asl (è l’ufficio di Igiene e Sanità pubblica che dispone l’isolamento), ma che viene trasmesso anche ai sindaci. Ciascun comune ha ricevuto una pec in cui si invitava a fornire l’indirizzo e-mail privato del primo cittadino, che ha avuto -solo lui e al di fuori dei documenti protocollati dall’ente- le credenziali informatiche per accedere all’elenco che viene aggiornato quotidianamente.
Quindi il sindaco sa quanti e quali suoi concittadini sono positivi al tampone e quali familiari, colleghi, amici o conoscenti del contagiato sono in isolamento. Questa notizia è utile per effettuare i controlli, per verificare che chi ha un’imposizione la rispetti. Ma la funzione di quella rete capillare territoriale che sono le comunità, termina qui, perché nessun Comune indaga o verifica chi può avere avuto contatti con i contagiati. Questa operazione è sempre in carico all’Asl, che non ha una conoscenza specifica delle persone, dispone di personale limitato e, soprattutto, deve gestire un territorio vasto nel quale i malati crescono di giorno in giorno.
Poniamo il caso che il cassiere di un supermercato, un operatore ecologico, un poliziotto, o chiunque in questi giorni si muove per lavoro ed è a contatto con il pubblico, sia positivo al Covid-19. Avvisare la popolazione che ciò è accaduto può agevolare i clienti del negozio, il residente che ha ritirato il bidone dell’umido svuotato, l’automobilista controllato. Chi ha avuto contatti con questa persona potrà mettersi in allerta, isolarsi dai propri cari, fare più attenzione a sintomi lievi come tosse e febbre (il problema della diffusione del Covid-19 sono gli asintomatici), contattare l’Asl. Anche questa è una misura di prevenzione, non inferiore al restare a casa. Anzi, più incisiva soprattutto nei paesi piccoli che sono ormai di fatto quasi del tutto bloccati e nei quali il virus si limita a pochi casi e può essere debellato.
Non è necessario comunicare nome e cognome, ma non dovrebbe essere un tabù farlo se serve a preservare la salute di tanti e, forse, a salvare qualche vita. E qui torna l’interrogativo iniziale, perché ci sono casi in cui le comunicazioni avvengono. In provincia di Como s’è scoperto che un medico di base era positivo. Il Comune ha diffuso un avviso in cui ha invitato gli ignari (né lui se li poteva ricordare tutti) pazienti passati dal suo ambulatorio, a contattare l’Asl. Il Tribunale di Alessandria ha scritto al personale e agli avvocati che un certo magistrato era stato contagiato, dando la stessa avvertenza. Idem al Tribunale di Milano con altri due giudici, di cui la stampa ha avuto l’indicazione della sezione di appartenenza.
Se, per ipotesi ma nemmeno troppo azzardata, un medico di famiglia del Vco, massimalista con 1.500 pazienti, avesse avuto il tampone positivo, i suoi pazienti avrebbero diritto a saperlo? L’Asl lo dovrebbe comunicare? Il sindaco? Non è la caccia all’untore, non è voyeurismo, ma una semplice misura di prevenzione, che comprime la libertà personale di uno per tutelare quella dei più.