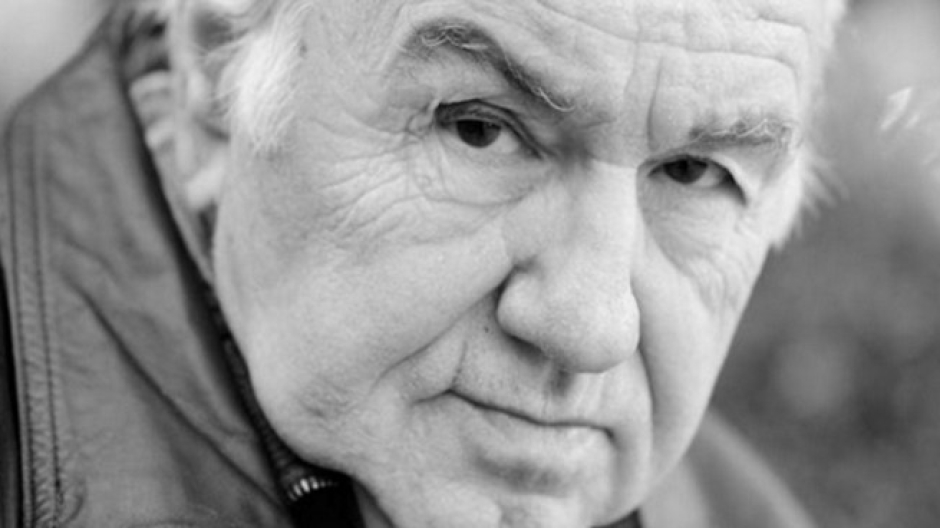RIMASCO – 19-8-2025 – Una storia centenaria che ha significato sviluppo per il territorio del Vercellese. È la storia della diga di Rimasco che proprio in questa estate ha compiuto il suo primo secolo. Ne abbiamo parlato col geologo Marco Zantonelli.
Qual è la storia di questa diga?
“Nel mese di Luglio 2025, la diga che sbarra il corso del T. Sermenza all’altezza dell’abitato di Rimasco, ha compiuto 100 anni. Essa rappresenta testimonianza di un periodo storico in cui, anche per la nascente autarchia cui il Regno italico si era consegnato, lo sfruttamento delle risorse energetiche rinnovabili legate alla forza motrice dell’acqua, era in forte crescita. Allora, pur esistendo rilevanti vincoli sul territorio (ad esempio il “Vincolo per scopi idrogeologici” promulgato nel 1923, a difesa delle pendici montuose o la tutela demaniale su molti corsi d’acqua dal Regio Decreto del 1904), le opere di prioritario interesse dello Stato seguivano iter molto più snelli, rispetto a quelli previsti dalle procedure di Valutazione di Impatto Ambientale che vanno soddisfatte nel presente.
Il grande sviluppo delle dighe ad utilizzo idroelettrico si è quindi avuto in Italia durante il ventennio fascista e poi nel primo dopo guerra. Con il disastro connesso alla costruzione della diga del Vajont del 1963, la realizzazione di nuovi rilevanti impianti idroelettrici ad invaso si è pressochè arrestato. Oggi sono molto diffusi impianti idroelettrici medio-piccoli che non necessitano di sbarramenti tipo diga e che possono sfruttare la caduta lungo brevi tratti di corsi d’acqua, principalmente montani.
Per contro sono piuttosto diffusi gli invasi tipo diga realizzati da parte dei consorzi di bonifica, al precipuo fine irriguo e acquedottistico. Nel Biellese ne ricordiamo almeno tre, la Diga sul T. Ravasanella a Sostegno, la Diga sul T. Ostola a Masserano e la Diga sul T. Ingagna a Mongrando.”
-Il territorio di Rimasco è propizio a questo tipo di infrastrutture?
“Nella programmazione per la realizzazione di un invaso, ove si privilegi la funzionalità idroelettrica, entrano in gioco molti elementi, in primo luogo di carattere morfologico e geologico, quindi climatico ed ecosistemico. Gli aspetti morfologici richiedono che sia individuabile una “stretta” in cui attestare il paramento della diga, ottenendo a monte un invaso sufficientemente ampio, comunque tale da non stravolgere quanto di preesistente si localizzi in tale settore (ad esempio un abitato storico), garantendo altresì significativo accumulo idrico. A ciò si aggiunga la necessità di determinare nel percorso di restituzione delle acqua, un salto di quota sufficiente a sviluppare adeguata forza motrice.
Altresì gli aspetti geologici devono favorire l’inserimento del paramento su di un substrato sufficientemente saldo, atto a garantirne la stabilità nel tempo. E’ inoltre fondamentale che la diga nel suo insieme non sia esposta a processi geomorfologici accelerati, tali da compromettere nel tempo gli equilibri preesistenti.
Al riguardo degli aspetti climatici, è preferibile che la diga ricada in un contesto caratterizzato alimentazione meteorica continua, anche se non è infrequente che invasi particolarmente capienti vengano realizzati in ambienti caratterizzati da semiaridi, proprio affinchè possano agire da regolatori nella distribuzione idrica a fini civili o irrigui.
E’ fondamentale che la realizzazione degli invasi non stravolga le caratteristiche ecosistemiche dei settori entro cui ricadono. A tale riguardo, in Italia, si è molto attenti alla salvaguardia del Deflusso Minimo Vitale (DMV), ovvero il rilascio idrico che deve essere garantito entro al corso d’acqua a valle della presa ed a monte della restituzione, affinchè possano essere mantenute inalterate le caratteristiche ecosistemiche dell’alveo naturale.
Fatte tali debite premesso, possiamo venire a parlare più dettagliatamente della diga di Rimasco. In tal caso la situazione è molto favorevole per la localizzazione del paramento, posto al margine di valle di un gradino morfologico, soprastante ad una forra rocciosa che vede sprofondare rapidamente l’alveo del T. Sermenza fino a Fervento, ove si trova la centrale di produzione ed il relativo rilascio idrico. Peraltro il bacino non è molto capiente, presentando sviluppo massimo di poco inferiore ad 1 km e capacità massima d’invaso nell’ordine di 500.000 mc. Altresì, ricadendo esso presso la confluenza del T. Egua nel T. Sermenza, anche in relazione alla brusca riduzione di pendenza che entrambi i corsi d’acqua palesano nel settore, l’invaso è esposto a ricorrente interrimento. Tale condizione è un elemento condizionante la vita di tutti i bacini idroelettrici: per alcuni, come per la diga di Rimasco, è ovviabile con interventi di svuotamento, i quali avvengono di norma almeno ogni ventina d’anni, per altri, in relazione a dimensioni e accessibilità, possono diventare antieconomici e portano alla morte del lago. Nel caso della Diga di Rimasco ho personalmente assistito quale consulente tecnico ai lavori di svuotamento ed adeguamento condotti dalla Ditta Notari Spa tra il 2015 ed il 2016, con i quali è stato altresì realizzato un nuovo canale sussidiario in sinistra, completamente scavato in roccia. E’ stata l’occasione per verificare la buona condizione di assestamento del paramento della diga, allora solo novantenne.”
Vi sono dei pericoli? E dei sistemi di sicurezza?
“Circa la potenziale pericolosità indotta da una diga quale quella di Rimasco, è bene precisare che ciascuna è dotata di un piano di crash-down, nel quale sono rappresentati gli scenari che deriverebbero dal possibile crollo della stessa. L’areale interessato dal potenziale deflusso dell’onda di piena conseguente al crollo, viene di norma rappresentato nell’ambito degli strumenti urbanistici comunali ed è utilizzato per l’elaborazione del Piano di Protezione Civile Comunale. Nel caso di fenomeni metereologici contrassegnati da livelli di allerta elevati (arancione e rossa), i ponti e le dighe diventano osservati speciali. In tale evenienza il deflusso delle dighe viene regolato anche in funzione di quello della piena naturale e, per invasi particolarmente capienti, tale possibilità può rappresentare un significativo vantaggio, al fine di ridurre gli afflussi a valle in caso di alluvione. Negli invasi più piccoli, onde di piena particolarmente impulsive e ricche di trasporto solido, possono influire negativamente sulla funzionalità della diga ed in particolare sulla regolazione delle apparecchiature meccaniche che governano il rilascio. In ogni caso, raggiunto il livello di colmo, la diga sfiorerà omogeneamente in sommità, restituendo nell’alveo una portata comparabile alla piena naturale.
Questa è di fatto la condizione che può caratterizzare, nella peggiore delle ipotesi la diga di Rimasco, mentre gli aspetti generali che caratterizzano la funzionalità della stessa, non prefigurano particolari scenari di rischio riconducibili ad ipotetico “effetto Vajont” o al potenziale crollo del paramento. In ultimo si rileva che non è esistente neppure un rilevante rischio sismico, considerata la bassissima sismicità che caratterizza il Comune di Alto Sermenza, in cui ricade l’abitato di Rimasco.”
Federico Zancaner